Trasmissione del sapere obsoleta ed inutile?
Come è possibile sviluppare ed esercitare un effettivo senso critico senza possedere i fondamenti di una solida matrice culturale, costituiti da quell’insieme di contenuti culturali, cognizioni, dati, informazioni, conoscenze, che però ormai sono bollati da più parti come un coacervo inutile di nozioni superflue?
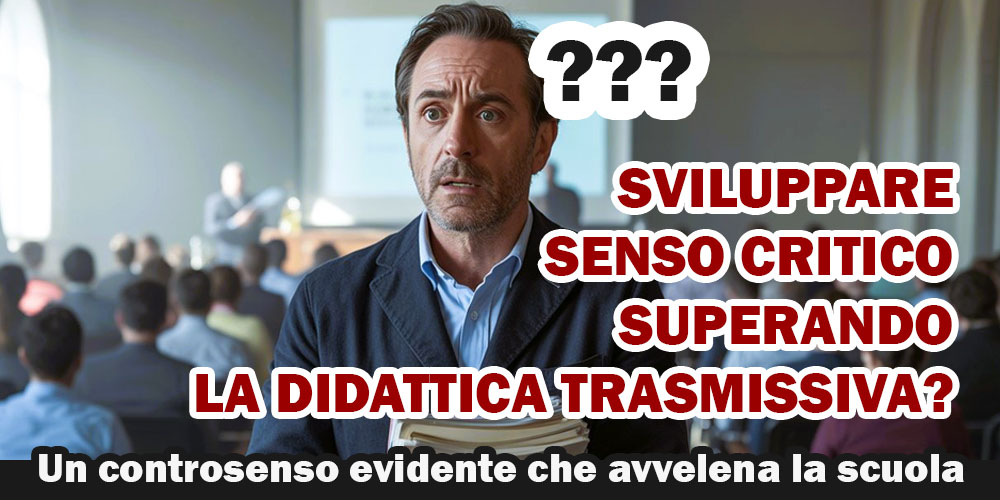
Nel dibattito sull’istruzione e la formazione dei giovani imperversa ormai fra pedagoghi, psicologi, docenti, studenti, un luogo comune che si ripete come un conformistico leitmotiv mediatico, forse perché sembra garantire il facile plauso del pubblico, e che poche voci osano contraddire apertamente e ufficialmente, sebbene la sua critica rispecchi l’opinione di una grande maggioranza dei docenti – di coloro cioè che sono in prima linea e a diretto contatto con i discenti nel lavoro di formazione educativa e culturale.
È l’idea che il ruolo dell’istituzione scolastica sia sì, fin dalla prima infanzia sino alla conclusione degli istituti superiori, quello di sviluppare il senso critico, lo spirito di intraprendenza e innovazione, la formazione di una coscienza etica, di una sensibilità sociale ma – e si noti la singolare condizione – tralasciando la trasmissione di conoscenze, informazioni, nozioni, considerati ormai un obsoleto bagaglio didattico del passato, reliquia di una visione basata sulla ricezione passiva dell’insegnamento da parte del discente di ogni età, reso superfluo dalla immane disponibilità di dati fornita oggi da Internet e dalla AI.
Ora, le finalità sopra elencate della formazione di un individuo sono proprio quelle di cui più che mai il mondo contemporaneo avrebbe bisogno, nel contesto attuale di disorientamento morale, civile, ideologico che l’Occidente sta vivendo: epperò, il discorso non regge da un punto di vista logico, perché ci chiediamo come sia possibile sviluppare ed esercitare un effettivo senso critico, una capacità di valutazione della realtà sociale in cui un giovane è inserito, acquisire una meditata consapevolezza etica, senza possedere i fondamenti di una solida matrice culturale, costituiti da quell’insieme di contenuti culturali, cognizioni, dati, informazioni, conoscenze, bollati invece come un coacervo inutile di nozioni, per di più trasmesse attraverso lezioni “frontali” considerate oggi l’archetipo di una concezione arcaica, autoritaria, dirigista dell’insegnamento, una trasmissione che imporrebbe di memorizzare passivamente contenuti superflui…
Mi spiego con un banale e attualissimo esempio: che senso ha svolgere in una classe un dibattito sulla guerra in corso in Ucraina, magari attraverso un debate ormai molto di moda, se la maggioranza dei discenti ignora con precisione dove si trovi e quali caratteristiche morfologiche territoriali abbia l’Ucraina (dato che lo studio delle geografia è stato ormai da anni quasi accantonato o bandito perché nozionistico, futile etc.)? Se non conosce nelle sue linee generali la storia della Russia e dell’Ucraina almeno dell’ultimo secolo? Se ignora il contesto più generale in cui il conflitto è nato? La riflessione, allora, sarà tutto fuorché “critica” e si risolverà nella vuota ripetizione di luoghi comuni indotti dai mass media, nell’accettazione di narrazioni superficialmente adottate a livello di massa.
Ciò significa che qualunque formazione educativa passa attraverso lo studio e l’assimilazione lenta, faticosa, talvolta frustrante di conoscenze specifiche, che non sono vuota erudizione o stantìo nozionismo, ma costituiscono le basi sulle quali costruire una propria visione personale delle cose, delle persone, della vita.
E così anche l’educazione affettiva o emotiva che dir si voglia non passa attraverso anodine e impensabili discipline specifiche, ma si sviluppa attraverso la conoscenza delle opere letterarie, nelle cui narrazioni il giovane può trovare risposte ai suoi dubbi, imparando indirettamente a conoscere che cosa sono pulsioni, emozioni, sentimenti, passioni, casi della vita, problematiche del passato e del presente. Oppure nello studio delle vicende storiche nelle quali è possibile riconoscere costanti dell’agire umano, purtroppo spesso poco nobili e ipocritamente mascherate, come sempre accaduto e come accade oggi più che mai. Altrimenti, tutto l’insegnamento rischia di risolversi in vaniloquio propagandistico, in illustrazione di slogan, di formule conformistiche, senza incidere davvero sulle coscienze, rese tabula rasa da un’abdicazione grottesca quanto dannosa a proporre, imporre, discutere e verificare contenuti disciplinari, quel complesso di dati che possono e devono essere rielaborati personalmente e quindi mettere in condizioni di capire se stessi, gli altri, la realtà circostante. Tutto il resto, qualunque scorciatoia didattica innovativa, magari supportata dal prestigio di una terminologia anglicizzante, si risolve in chiacchiera che copre la realtà di una sorta di analfabetismo culturale e psicologico di ritorno.

Eccellente analisi, il leitmotiv “insegnare il senso critico” ormai va per la maggiore e suscita un superficiale consenso mediatico, chi può negare che non sia una cosa buona e giusta.
In realtà come benissimo mostrato nell’articolo è quasi un ossimoro, somiglia al dire a un depresso “sii felice”, in sostanza un’assurdità bella e buona. Il senso critico può emergere, lentamente e individualmente, solo sulla base di un lungo, complesso, e impegnativo percorso nel quale è centrale un’ istruzione e quindi una scuola seria e il più possibile plurale e pluralistica.
Non esistono scorciatoie.
Se ci è consentito essere, ancora una volta, dei discepoli del sospetto, questo tanto sbandierato quanto spettrale “senso critico” in opposizione alla conoscenza delle cose, è forse il rifiuto confuso del dato oggettivo. Un’idea nebulosa che va a coprire la normale insofferenza adolescenziale, fatta però colpevolmente propria e propagandata da adulti, per ciò che *resiste* all’imperialismo di un soggettivismo indisciplinato. Una foglia di fico che va a coprir e la confusione e che -soprattutto- va ad appagare le ingenue aspettative di genitori in cerca di alibi per se stessi e per i loro figli. Come giustamente sottolinea l’autore, è solo il possesso di una cultura che sia anche memoria storica di dati trasmessi tra generazioni, dalle varie comunità di appartenenza, che fornisce elementi per l’esercizio di una critica reale, non sofistica e non cavillosa delle cose. Si avverte, fra le righe di questo testo, lo sforzo dell’autore di confrontarsi con baggianate di tale portata che un tempo non sarebbero state neanche prese in considerazione. Il primo merito di Falsoni è quindi quello di sapersi chinare, da insegnante, su queste deiezioni e di farne oggetto di paziente *critica*.