Splendore e miseria del Matim
Molti docenti ricorderanno il manuale di letteratura italiana “Il materiale e l’immaginario”, edito per la prima volta nel 1979, un ambizioso tentativo di storia totale in cui lo specifico della letteratura inevitabilmente risultava di fatto sminuito, marginalizzato, ovvero posto al servizio della Storia tout court.
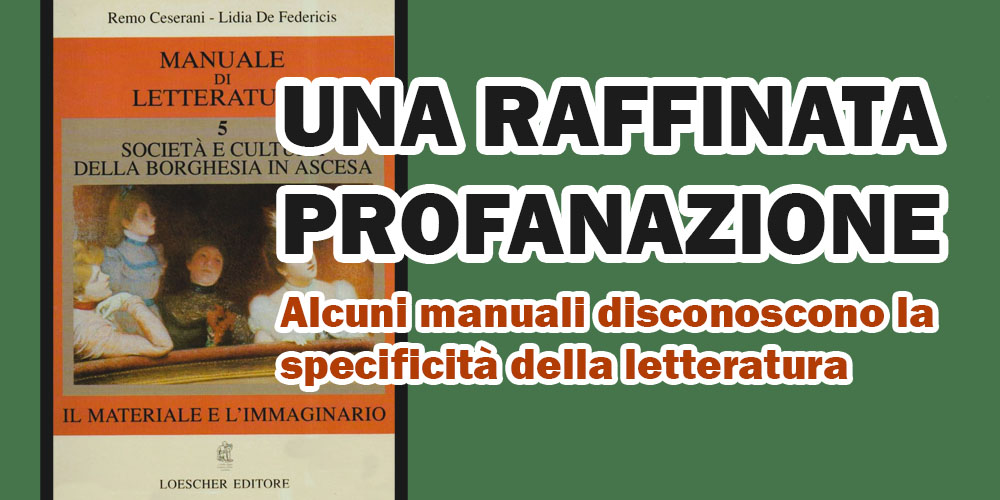
Nella teoria e nella pratica didattica degli ultimi decenni è stato molto influente da noi – molti lo ricorderanno – il manuale di letteratura italiana Il materiale e l’immaginario, detto sinteticamente Matim. Diplomatomi nel 1974 non feci in tempo a conoscerlo come studente perché uscì, nella prima edizione, nel 1979. E quando, pochi anni dopo, nella prima metà degli anni Ottanta, cominciai a insegnare, la sua diffusione nelle scuole cominciava già lentamente a declinare. Per fortuna, aggiungerei adesso. Quel manuale infatti, qualcuno lo ricorderà, scompaginava e frantumava la trattazione sistematica dell’insegnamento della nostra letteratura per riproporne gli autori e i testi spesso più in subordinazione che in relazione alla storia, alla antropologia, alla sociologia ecc. Allora questa novità del Matim dovette sembrare a molti colleghi che lo adottarono straordinaria, geniale, avanzata. A considerarla tale contribuirono molto i tempi e l’humus culturale in cui quella ipertrofica impresa editoriale (una decina abbondante di poderosi volumi: alla faccia del manuale!) affondava le radici. Ma il difetto di fondo da cui, secondo me, quell’opera era viziata, il suo peccato originale, consisteva appunto nel disconoscimento oggettivo (o tendenziale) del valore e della specificità della letteratura, cioè – in buona sostanza – dell’autonomia dell’arte. Così combinata, presentata cioè come componente ovvero appendice o frangia sovrastrutturale della Storia e della Società umane, la creazione letteraria non appariva più tanto, nel Matim, il frutto di un intendimento artistico individuale, quanto un documento, per quanto speciale, utile soprattutto ad integrare le scienze umane nel compito di ricostruire le condizioni socioeconomiche e politiche, oltre che la temperie e il patrimonio culturale, di un’epoca. Un ambiziosissimo, discutibile e un po’ magmatico tentativo di storia totale (sulla scorta dei famosi Annales) in cui lo specifico della letteratura inevitabilmente risultava – se non teoricamente disconosciuto – di fatto sminuito, marginalizzato, ovvero posto al servizio della Storia tout court.
Il Matim era insomma, in buona sostanza, una strumentalizzazione della letteratura a fini eterogenei. Un disconoscimento della sua autonomia e del suo valore intrinseco. Seppur perpetrato in nome di una visione culturale (prima che didattica) moderna e raffinata, si trattava comunque, a mio modo di vedere, di una sorta di profanazione, di ‘sacrilegio’.
A distanza di decenni, per altro, non nutro molti dubbi che il Matim sia un lontano ma sicuro e non proprio incolpevole progenitore di molte altre recenti profanazioni, critiche e didattiche, compiute in buona e in cattiva fede, della letteratura. Non certo perché il Matim le abbia da par suo perpetrate tutte, ma perché con la sua notorietà ed il suo esempio tutte le ha, in linea di principio, accreditate.
Procedendo da quell’illustre modello, infatti, si può scendere, di banalizzazione in banalizzazione, fino a strumentalizzare e a svilire (come è accaduto in un recente manuale) Rosso Malpelo di Verga associandovi un compito di realtà come la preparazione di un dépliant turistico della Sicilia.
Si può fare qualcosa, volendolo, contro le facili attrattive e le conseguenze insidiose di questo modello? Non moltissimo, direi, perché le mode (culturali e didattiche) hanno oggi più che mai, nella nostra scuola, un peso schiacciante e si protraggono spesso anche per comoda inerzia. Ma gli insegnanti sensibili al problema potrebbero intanto, di volta in volta, impegnarsi a smascherare e a contestare davanti agli alunni le molteplici e talvolta volgari strumentalizzazioni sparse in vari manuali di letteratura. Anche la critica argomentata dei libri di testo fa parte (e come!) di una buona pratica didattica. Ma soprattutto, se questi insegnanti ritengono che alcuni testi perseguano in maniera sistematica e fuorviante quella linea, essi dovrebbero evitare semplicemente di (ri)adottarli, motivando davanti a colleghi e ragazzi la loro scelta.
Molti anni fa caddi anch’io in un tranello del genere. Allettato dall’autorevolezza indiscutibile di un grecista come Luciano Canfora, ne adottai troppo frettolosamente il manuale di letteratura greca. Poi mi accorsi presto, usandolo, che era un manuale di storia e di civiltà greca mascherato da storia letteraria: che utilizzava, cioè, i testi della letteratura classica quasi esclusivamente per il loro (notevole) interesse documentario e/o politico-culturale in relazione all’Atene del V secolo. Un’operazione in parte non dissimile, nella sostanza, a quella messa in atto per la letteratura italiana dal Matim. Tanto per fare un esempio: Canfora in quel suo manuale aiutava me (insegnante) a indagare e a capire benissimo i riferimenti all’attualità storico-politica impliciti nelle tragedie classiche, ma trascurava del tutto di guidare i ragazzi sia nell’analisi della loro forma poetica e drammaturgica sia soprattutto nell’interpretazione dei significati profondi e metastorici – esistenziali e morali – che sono alla fin fine – insieme alla loro indiscutibile qualità estetica – ciò che resta di più importante e di prossimo (in quanto eterno e universale) per un lettore moderno della tragedia greca, così come di ogni altra (ed alta) forma di espressione letteraria del passato. Insomma, anche qui, Litterae ancillae Historiae factae sunt. Conservo ancora quel manuale, di per sé comunque molto stimolante sul piano scientifico. Ma non lo riadottai più.
Paolo Mazzocchini è curatore del blog SATURALANX – ScritturaMista.
