Collegamenti
Per fare collegamenti bisogna conoscere ciò che si vuole collegare
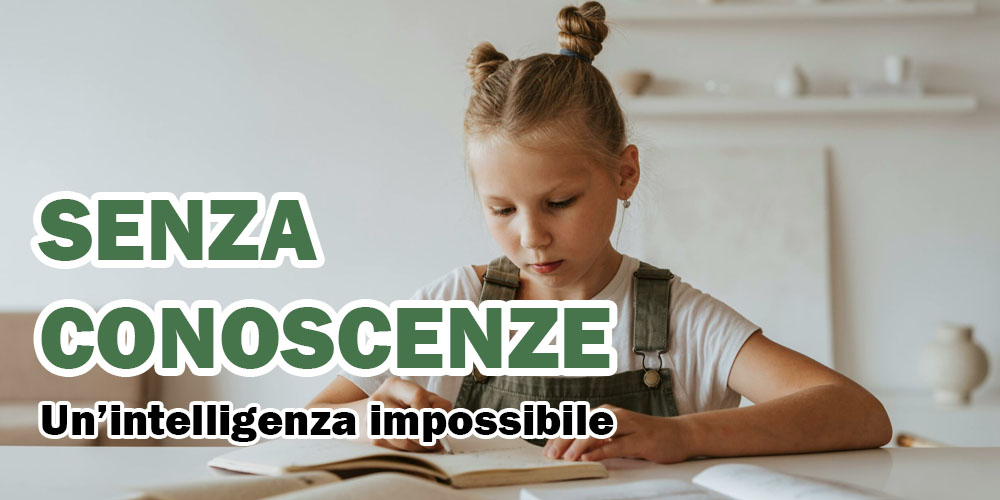
Ci sono parecchi modi in cui possiamo definire l’intelligenza umana, anche a seconda del contesto in cui ne parliamo. Se ci atteniamo all’etimologia (“intelligenza”, da intus-legere = leggere dentro) non possiamo evitare di pensare alla capacità di penetrazione nelle cose della realtà, e delle loro leggi, ricavandone un’immagine oggettiva. Nel pensiero intelligente le cose (e le parole) si rapportano tra loro in modo corretto, definendosi reciprocamente; tanto più i loro rapporti si articolano, quanto più la penetrazione della realtà sarà profonda. Nel pensiero intelligente la realtà trova le sue spiegazioni. Il pensiero intelligente coglie la necessità di quelle spiegazioni e quindi è anche in grado di fare previsioni.
Ora, è evidente a tutti che una persona intelligente riesce a cogliere un grande numero di relazioni tra le cose, cioè sa collegare tra loro le parole in modo da creare una rete di significati pertinente, che merita attenzione e riflessione, e che può essere una guida anche per la dimensione pratica.
La scuola si occupa della conoscenza esplicativa delle discipline di studio e dunque ambisce a sviluppare prima di tutto un’intelligenza di tipo teorico, che getti luce pure sui principi che devono guidare l’azione individuale. La scuola, proprio come la vita, non può però indurre l’intelligenza di per sé, in modo diretto. Infatti la capacità di fare collegamenti comprende due momenti distinti:
(1) la conoscenza del significato delle cose e delle parole della realtà, che viene di-spiegata dagli insegnanti e messa a disposizione degli allievi che vogliano farla propria;
(2) l’effettiva creazione di collegamenti originali tra le parole (tra i concetti), che è il risultato – creativo e per certi versi insondabile – dell’atto di pensiero di ciascuno. I collegamenti tra le parole non sono esterni e casuali, ma si fondano nelle parole stesse, dando origine ai giudizi.
Il primo momento rimanda alla scuola, alla relazione con un maestro; mentre sul secondo la scuola e gli insegnanti non hanno alcun potere (è il momento che Agostino risolveva chiamando in causa la Grazia). Esso dipende per intero da quello che accade all’interno dell’allievo.
Dunque? Dunque dobbiamo rassegnarci. Il meglio che la scuola possa fare è insegnare tante parole e tante cose mostrando la ricchezza di riferimenti che esse contengono, così da stimolare l’allievo a un’ulteriore riflessione su ulteriori possibili riferimenti: parlo delle famigerate nozioni. Senza le nozioni non c’è nulla da collegare.
Credo significhi molto. Moltissimo.
P. S. Coloro che, a partire da quanto ho scritto, si accaniscono contro lo studio mnemonico favoleggiando di un totale attivismo generativo da parte dell’allievo non hanno forse compreso che la creatività poggia sempre sulla padronanza oggettiva di conoscenze elementari (si pensi alle tabelline, o all’alfabeto) che non possono prescindere dalla memoria dei termini da utilizzare, e che il significato di quei termini non dipende da un atto creativo.

Sinceramente no, non amo scrivere risposte intellettualoidi.
Ma quando leggo certe stronzate che affermano che pensiero e linguaggio coincidono (caxata ereditata dagli anni “20 in cui si riteneva che il linguaggio fosse prerogativa umana, caxata poi smentita dalla scienza e dalla sua scoperta dei linguaggi animali).
Più semplicemente: non avete mai letto cavolate scritte con linguaggio forbito?
Non avete mai letto cose intelligenti scritte con un linguaggio semplice e sgrammaticato?
Se non potessimo pensare al di fuori delle parole che usiamo, il linguaggio sarebbe qualcosa del tutto statico, dato che in ogni momento della storia, il complesso delle parole che utilizziamo sarebbe sempre sufficiente a esprimere la nostra visione del mondo. In realtà, il linguaggio cambia continuamente proprio perché sussiste un incolmabile scarto tra idee e parole, modifichiamo il linguaggio per rendere il più possibile adeguato a esprimere il pensiero, associamo parole a idee, perché reputiamo quelle idee “degne” di essere comunicate. Ma questo “reputare degne” quelle idee è un atto intuitivo pre-linguistico che rende possibile il linguaggio stesso. Il linguaggio è sempre costantemente in ritardo rispetto al pensiero, che lo anticipa e lo trascende. Per reputare degna un’idea di essere espressa verbalmente, devo per forza pensarla, e dunque quel “pensarla” precede” la verbalizzazione linguistica.
non è in discussione la necessità della condivisione del pensiero, cioè del linguaggio, per l’esistenza, ma la tesi della coincidenza dei limiti del linguaggio con quelli del pensiero. Se la verbalizzazione di un’idea ne presuppone l’intuizione del suo valore (e l’intuizione è già pensiero), allora deve esistere un livello della coscienza profondo, pre-linguistico, in cui i pensieri sono valutati riguardo l’opportunità di associarli a delle parole per comunicarli o meno, lavoro interiore e latente della coscienza che anticipa il linguaggio e ne determina le evoluzioni storiche.
un conto è riconoscere un’influenza del linguaggio sul pensiero, un altro sarebbe estremizzare questa influenza arrivando a vedere il linguaggio come origine del pensiero o come definente i limiti di quest’ultimo. Io ne faccio un discorso di logica: come posso associare una parola a un’idea senza già in partenza avere un pensiero di quell’idea tale da riconoscerla meritevole di essere comunicata socialmente? Per quanto riguarda le ricerche dei linguisti: si tratta di approcci basati sul metodo empirico che possono considerare la componente più esteriore e superficiale dell’uomo, il comportamento, il modo in cui si esprime comunicativamente, mentre la tesi dell’anterioriota’ del pensiero rispetto al linguaggio presuppone il riconoscimento di una dimensione della coscienza interiore e spirituale che andrebbe discussa in termini filosofici e metafisici, non empirici, a cui sfugge la profondità umana. Che una persona isolata dal linguaggio si comporti come “non pensante” non vuol dire che sia priva di pensiero tout court, ma solo che il pensiero resti latente nelle profondità inconsce della psiche. Ma il comportamento esterno non esaurisce la personalità (a meno di non fare del positivismo) e un conto è ammettere che il linguaggio stimoli il pensiero a esprimersi in superficie, un altro che lo crei dal nulla.
Quindi i muti non possono pensare. O gli afasici, non hanno pensieri. Esistono processi cognitivi evoluti indipendenti dalle parole, e processi di apprendimento altrettanto indipendenti. Come esistono perfetti idioti, che conoscono tantissime parole. Male, egregio professore, molto male. Siccome sono cose che certamente conosce, e certamente conosce gli esperimenti noti da decenni, sui danni nelle aree del Broca…. questi soggetti non erano affatto a-pensanti. Studi e posizioni poi confermate da ricerche sia di neuroimaging, sia sulla plasticità del cervello… Allora non posso credere nell’ingenuità: lei usa le sue conoscenze, per altre finalità. Malissimo. Si chiama “intossicazione dell’informazione”.
La parola é funzionale all’espressione, ma il cervello ha in mente i concetti senza necessariamente avere in mente una parola che li definisce oppure definisce definizioni interne funzionali. Un altro esempio per illustrare questo processo é usare la grammatica. Alcune lingue hanno due casi distinti per il soggetto (soggetto causativo e soggetto oggettivo) questo significa che noi italiani non sappiamo distinguere quando il soggetto é causa dell’azione o oggetto dell’azione?
In sintesi: ma vaffà….
Lei è solo un maleducato.
Il suo commento è importante: é la dimostrazione (empirica) che la tesi dell’articolo è valida. Ed è anche un ottimo esempio di eterogenesi dei fini.
“Il sapere concettuale è il culmine di una cultura”, Hegel.
(A. Peperzak)
Il commentatore dell’articolo, sempre ammesso che egli non stia “trollando”, sembra forse aderire alla convinzione che esista il cosiddetto “mentalese”. Se devo essere sincero avrebbe potuto esprimere più pacatamente questa (non nuovissima) posizione risparmiandosi certi accenti fastidiosamente e inutilmente sciamannati; forse derivanti da una emotività che non riesce a tradursi adeguatamente in linguaggio, mantenendo un residuo non linguistico che la mantiene sottotraccia assai vicino semanticamente alla fonazione inarticolata.
Non mi pare comunque -e questo è l’importante- che, anche aderendo ad una posizione come la sua, si possa per ciò stesso pervenire ad una confutazione didattica o cognitiva di quanto sostiene Sagredo. Insomma comunque la giriamo lo studio, in attesa dell’insettino di Matrix portatore di luminose conoscenze gratuite, non è il Club Meditarranée. Ma è proprio questo che non piace agli “amici dei ragazzi”.
Purtroppo una molesta congiuntivite mi impedisce di approfondire maggiormente la questione.
Da prof. Sagredo peraltro /e lo devo dire/ mi divide una grande, insanabile e importante convinzione di carattere morale: interventi come questo così “intellettualoide” (sic) di “luino”, nella mia bacheca non avrebbero durato 5 minuti.